Verbier Festival 2009
Amadeus, Ottobre 2009
Your browser does not support viewing this document. Click here to download the document.
Concerto dei pianisti Evgenij Kissin e Jean-Yves Thibaudet
Verbier Festival Orchestra
Direttore Charles Dutoit
Verbier, 26 Luglio 2009
The Classic Voice

Il concerto che ha avuto luogo il 26 luglio alla Salle
Medran, il grande teatro-tenda che ospita le manifestazioni più importanti del
Festival di Verbier, era destinato a rimanere uno degli appuntamenti di punta
della sedicesima edizione del festival stesso ma si prestava anche ad alcune
considerazioni di non poco conto sullo stato di salute della cosiddetta musica
classica.
Un accostamento poco tradizionale vedeva infatti succedersi il Concerto in fa minore di Chopin e la monumentale Turangalila-Symphonie di Messian, denominatore comune la esperta bacchetta di Charles Dutoit. Ma i pianisti impegnati nelle rispettive parti solistiche erano due, agli antipodi per quel che riguarda la concezione interpretativa e la curiosità nei confronti del repertorio. Evgenij Kissin suonava così impeccabilmente lo Chopin giovanile, accentuando a nostro parere fin troppo la lenta declamazione dei florilegi che accompagnano la dizione dei temi del primo movimento, tanto che si faticava a ricomporre lo schema architetturale che pure in Chopin è sempre ben presente. Una interpretazione che guarda indubbiamente al passato remoto, alla quale avremmo preferito la classica compostezza (non priva di sentimento !) di un Rubinstein.
D’altro canto Jean-Yves Thibaudet si immergeva anima e corpo nell’impegnativa (e lunga) partitura di Messiaen coadiuvato alla perfezione da Dutoit, facendo rivivere al pubblico le stesse emozioni che devono avere suscitato le prime esecuzioni del lavoro alla fine degli anni ’40. Una partitura che risente molto degli influssi di Stravinskij e persino di Gershwin ma che sembra tendere a un sincero messaggio di ‘musica totale’ che non ha confini né spaziali né temporali.
Alla fine della serata, tra i due pianisti è risultato vincitore senz’altro Thibaudet, che ha rischiato di far apparire Kissin come un vecchio pianista di sana tradizione, con i suoi bis in parte omaggio a Horowitz (una “Soirée de Vienne” di Liszt-Schubert) in parte omaggio a una scontata convenzione chopiniana (il “Valzer del minuto” !).
Il successo di pubblico è stato molto grande e in gran parte gli applausi sono stati rivolti all’orchestra giovanile del Festival, che non ha certo risparmiato le proprie forze nell’esecuzione del gigantesco lavoro di Messiaen.
Un accostamento poco tradizionale vedeva infatti succedersi il Concerto in fa minore di Chopin e la monumentale Turangalila-Symphonie di Messian, denominatore comune la esperta bacchetta di Charles Dutoit. Ma i pianisti impegnati nelle rispettive parti solistiche erano due, agli antipodi per quel che riguarda la concezione interpretativa e la curiosità nei confronti del repertorio. Evgenij Kissin suonava così impeccabilmente lo Chopin giovanile, accentuando a nostro parere fin troppo la lenta declamazione dei florilegi che accompagnano la dizione dei temi del primo movimento, tanto che si faticava a ricomporre lo schema architetturale che pure in Chopin è sempre ben presente. Una interpretazione che guarda indubbiamente al passato remoto, alla quale avremmo preferito la classica compostezza (non priva di sentimento !) di un Rubinstein.
D’altro canto Jean-Yves Thibaudet si immergeva anima e corpo nell’impegnativa (e lunga) partitura di Messiaen coadiuvato alla perfezione da Dutoit, facendo rivivere al pubblico le stesse emozioni che devono avere suscitato le prime esecuzioni del lavoro alla fine degli anni ’40. Una partitura che risente molto degli influssi di Stravinskij e persino di Gershwin ma che sembra tendere a un sincero messaggio di ‘musica totale’ che non ha confini né spaziali né temporali.
Alla fine della serata, tra i due pianisti è risultato vincitore senz’altro Thibaudet, che ha rischiato di far apparire Kissin come un vecchio pianista di sana tradizione, con i suoi bis in parte omaggio a Horowitz (una “Soirée de Vienne” di Liszt-Schubert) in parte omaggio a una scontata convenzione chopiniana (il “Valzer del minuto” !).
Il successo di pubblico è stato molto grande e in gran parte gli applausi sono stati rivolti all’orchestra giovanile del Festival, che non ha certo risparmiato le proprie forze nell’esecuzione del gigantesco lavoro di Messiaen.
Festival della valle d'Itria
Martina Franca, Luglio 2009
Sipario

Proseguendo nel cammino intrapreso
in questi ultimi anni, cioè da quando il criterio di scelta esclusiva di autori
nati od operanti nell’Italia meridionale è stato preso un poco meno alla
lettera, il Festival della Valle d’Itria ha presentato nella apertura di
stagione 2009 due opere delle quali una era una vera e propria rarità, il Re Lear di Cagnoni, ultimo lavoro del
musicista lombardo, mentre la seconda si riferiva a una rivisitazione dell’Orfeo di Gluck appositamente approntata
per una antica esecuzione napoletana. La versione originale dell’Orfeo messa in scena a Vienna nel 1762 è
talmente nota e rappresentata da non costituire certo una novità appetitosa per
il Festival. Ma se i caratteri principali di questo testo classico, dove
vengono banditi eccessivi virtuosismi canori e si dà vita alle forme
convenzionali dell’epoca introducendo tra l’altro elementi corali e danzanti,
vengono contraddetti da una contaminazione volta a ... riportare le cose
all’ordine, ecco allora che si presenta una ghiotta occasione per il pubblico
di oggi, o almeno per gli addetti ai lavori, sempre curiosi in fatto di
riscoperte. E’ questo il caso della versione ripescata a Martina Franca, che
comprende inserti ad opera di Johann Christian Bach, il Bach londinese, scritti
in occasione di una rappresentazione dell’Orfeo a Londra, ripresa poi a Firenze
e a Napoli. Inserti che dilatano le proporzioni molto concise del capolavoro di
Gluck e ne attenuano i caratteri innovativi, in linea con il gusto tradizionale
dell’epoca. Proprio sulla rappresentazione napoletana del 1774 si è fatto conto
quest’anno a Martina Franca, con una operazione che ovviamente si proponeva di illustrare
una convenzione desueta, di dare un resoconto su questo modo del tutto fuori
luogo di accogliere un capolavoro musicale rinunciando ad esaltarne proprio le
caratteristiche più rivoluzionarie. Diciamo subito che le differenze tra la
partitura originale e gli innesti di Bach erano percepibili anche da un
ascoltatore inesperto, tanto stridente è la differenza tra il clima ombroso,
elegiaco della musica di Gluck e quello molto più enfatico e brillante di Bach.
Un esempio su tutti, l’aria bachiana «La legge accetto, o dèi» con la quale
Orfeo annuncia la sua discesa agli inferi, che con i suoi virtuosismi (il
famoso castrato che si produsse in quest’aria era Giusto Ferdinando Tenducci)
contraddice la prima parte malinconica e autunnale della versione originale di
Gluck. Su questo gioco di alternanze musicali ha avuto la meglio la spiritosa
regia di Toni Cafiero e le scene di Eric Soyer che si sono fatte un po’gioco
del pastiche napoletano inventando ad esempio ambienti sado-maso per la corte
di Plutone e di Proserpina. La direzione di Aldo Salvagno ha tenuto bene lo
spettacolo e in un certo modo affascinanti sono state le voci del controtenore
François Razek Bitar nel ruolo principale, del sopranista Angelo Bonazzoli – a
volte un poco stridulo – nel ruolo di Amore e dell’Euridice di Daniela Diomede.
Di genere completamente diverso era invece la scelta relativa a Cagnoni (1828 – 1896), una delle tante voci eclissate nel corso dell’ottocento dalla presenza del genio verdiano e già protagonista qualche anno fa di un azzeccato ritrovamento da parte del Festival, quello del Don Bucefalo.
E proprio a Cagnoni toccò la sorte di porre in musica quel Lear che aveva rappresentato un vero e proprio cruccio per Verdi, un progetto tanto caro al compositore di Otello e mai portato a compimento. Sulla base del libretto messo a punto da Ghislanzoni nel 1885, Cagnoni completò l’opera nel ’93, ma per varie vicende il Lear non venne mai rappresentato e solamente oggi, grazie anche alla revisione curata da Anders Wiklund per la Ricordi, il pubblico è riuscito ad ascoltare un lavoro non geniale e neanche tanto rappresentativo della stagione di rinnovamento che il melodramma italiano viveva in quel periodo. Si tratta in altre parole di un melodramma che potrebbe essere stilisticamente ricondotto indietro nel tempo di quarant’anni almeno e che tutto sommato rende palese i motivi dell’oblio nel quale è caduta tutta la produzione di Cagnoni. Pur con questi limiti, lo spettacolo illustrato dalle scene minimaliste di Nicola Rubertelli è risultato più che funzionale e si è avvalso della grande competenza di Massimiliano Caldi nel ruolo di concertatore. Quest’ultimo ha guidato al successo una compagnia di canto che vedeva brillare in particolare le voci di Costantino Finucci e di Danilo Formaggia.
L’imprinting dato al Festival della Valle d’Itria dall’indimenticabile Rodolfo Celletti nell’oramai lontano 1980 e parzialmente modificato durante la direzione artistica di Sergio Segalini, iniziata nel ’94, farà sentire ancora il suo effetto nella prossima edizione 2010 della manifestazione, questo è quasi certo. Cosa accadrà a partire dal 2011 è ancora tutto da scoprire, visto che con decisione relativamente inaspettata la direzione del Festival ha recentemente annunciato la nomina di un nuovo Direttore artistico nella persona di Alberto Triola, già nei ranghi della Scala e oggi collaboratore di Marco Tutino al Comunale di Bologna. Vi è solo da augurarsi che il Festival non vada a sconfessare la propria valorosa appartenenza a un genere di manifestazioni di élite (nel senso più positivo del termine), rinunciando a quel continuo lavoro di ricerca e recupero del repertorio meno consueto che è stato caratteristica delle gestioni appena concluse. Una virata verso un tipo di programmazione più “popolare” non farebbe altro che abbassare il livello del Festival a quello di un inutile doppione di manifestazioni festivaliere meno blasonate e toglierebbe a Martina Franca la prerogativa di rimanere un polo di attrazione per un pubblico affezionato e competente.
Di genere completamente diverso era invece la scelta relativa a Cagnoni (1828 – 1896), una delle tante voci eclissate nel corso dell’ottocento dalla presenza del genio verdiano e già protagonista qualche anno fa di un azzeccato ritrovamento da parte del Festival, quello del Don Bucefalo.
E proprio a Cagnoni toccò la sorte di porre in musica quel Lear che aveva rappresentato un vero e proprio cruccio per Verdi, un progetto tanto caro al compositore di Otello e mai portato a compimento. Sulla base del libretto messo a punto da Ghislanzoni nel 1885, Cagnoni completò l’opera nel ’93, ma per varie vicende il Lear non venne mai rappresentato e solamente oggi, grazie anche alla revisione curata da Anders Wiklund per la Ricordi, il pubblico è riuscito ad ascoltare un lavoro non geniale e neanche tanto rappresentativo della stagione di rinnovamento che il melodramma italiano viveva in quel periodo. Si tratta in altre parole di un melodramma che potrebbe essere stilisticamente ricondotto indietro nel tempo di quarant’anni almeno e che tutto sommato rende palese i motivi dell’oblio nel quale è caduta tutta la produzione di Cagnoni. Pur con questi limiti, lo spettacolo illustrato dalle scene minimaliste di Nicola Rubertelli è risultato più che funzionale e si è avvalso della grande competenza di Massimiliano Caldi nel ruolo di concertatore. Quest’ultimo ha guidato al successo una compagnia di canto che vedeva brillare in particolare le voci di Costantino Finucci e di Danilo Formaggia.
L’imprinting dato al Festival della Valle d’Itria dall’indimenticabile Rodolfo Celletti nell’oramai lontano 1980 e parzialmente modificato durante la direzione artistica di Sergio Segalini, iniziata nel ’94, farà sentire ancora il suo effetto nella prossima edizione 2010 della manifestazione, questo è quasi certo. Cosa accadrà a partire dal 2011 è ancora tutto da scoprire, visto che con decisione relativamente inaspettata la direzione del Festival ha recentemente annunciato la nomina di un nuovo Direttore artistico nella persona di Alberto Triola, già nei ranghi della Scala e oggi collaboratore di Marco Tutino al Comunale di Bologna. Vi è solo da augurarsi che il Festival non vada a sconfessare la propria valorosa appartenenza a un genere di manifestazioni di élite (nel senso più positivo del termine), rinunciando a quel continuo lavoro di ricerca e recupero del repertorio meno consueto che è stato caratteristica delle gestioni appena concluse. Una virata verso un tipo di programmazione più “popolare” non farebbe altro che abbassare il livello del Festival a quello di un inutile doppione di manifestazioni festivaliere meno blasonate e toglierebbe a Martina Franca la prerogativa di rimanere un polo di attrazione per un pubblico affezionato e competente.
Recital del pianista Maurizio Pollini
Teatro alla Scala, 21 Giugno 2009
The Classic Voice n.122-123

Dopo più di 24 anni dalla sua precedente esecuzione
scaligera Pollini ha presentato nuovamente al pubblico milanese quello che è
probabilmente il testo più famoso mai scritto per la tastiera. La tastiera
appunto, quella del clavicordo o del clavicembalo, non quella del pianoforte
che innescò almeno fin dai tempi di Mendelssohn una meravigliosa serie di
riscoperte che hanno lasciato l’imprinting
su quasi tutte le interpretazioni successive di questo capolavoro. Diciamo
senza mezzi termini che la differenziazione di timbro possibile sul moderno
pianoforte si presta assai bene a porre in evidenza il complicato gioco di
intrecci che va a costituire il contrappunto bachiano, e in tal senso si rivela
essere una fonte di sommo piacere estetico. L’ultima incisione del Clavicembalo effettuata da Barenboim, ad
esempio, ricca di raffinatissima vitalità pianistica, espone come meglio non si
potrebbe ogni entrata delle voci, le diminuzioni e gli aumenti, il moto retto e
contrario, senza che l’ascoltatore debba per forza prendere lo spartito in mano
e rendersi conto di ogni dettaglio del segno scritto.
A me sembra che Pollini, allora come oggi, rifiuti quasi interamente questa tradizione oramai secolare, e ritorni a quello che probabilmente era il modo di suonare Bach in era preottocentesca (forse lo suonava così anche il piccolo Ludwig van, costretto dal padre ?) senza cioè poter utilizzare il timbro in senso descrittivo. Il problema è che il mezzo del quale si serve Pollini è appunto il moderno pianoforte e allora i conti non tornano del tutto. Si ammira la coerenza stilistica assoluta, si ammira l’immane tour de force di memoria, si ammirano certi richiami metastorici che ci colgono di sorpresa, come l’ascoltare dal suono granitico del pianista certe analogie tra la fuga in si minore e la sezione del Canon cancrizans nella 106 di Beethoven, ma si perde d’altro canto una visione multidimensionale del contrappunto che rende più “piacevole” l’ascolto. Si è trattato in ogni caso di una impresa che ha richiesto all’interprete una immane concentrazione e partecipazione emotiva, salutata alla fine dall’affetto inestinguibile del pubblico tutto e da un fraterno abbraccio da parte di un emozionato Barenboim.
A me sembra che Pollini, allora come oggi, rifiuti quasi interamente questa tradizione oramai secolare, e ritorni a quello che probabilmente era il modo di suonare Bach in era preottocentesca (forse lo suonava così anche il piccolo Ludwig van, costretto dal padre ?) senza cioè poter utilizzare il timbro in senso descrittivo. Il problema è che il mezzo del quale si serve Pollini è appunto il moderno pianoforte e allora i conti non tornano del tutto. Si ammira la coerenza stilistica assoluta, si ammira l’immane tour de force di memoria, si ammirano certi richiami metastorici che ci colgono di sorpresa, come l’ascoltare dal suono granitico del pianista certe analogie tra la fuga in si minore e la sezione del Canon cancrizans nella 106 di Beethoven, ma si perde d’altro canto una visione multidimensionale del contrappunto che rende più “piacevole” l’ascolto. Si è trattato in ogni caso di una impresa che ha richiesto all’interprete una immane concentrazione e partecipazione emotiva, salutata alla fine dall’affetto inestinguibile del pubblico tutto e da un fraterno abbraccio da parte di un emozionato Barenboim.
Recital del pianista Lang Lang
Milano, Teatro alla Scala, 7 Giugno 2009
The Classic Voice n.122-123

Preceduto da una eco mediatica davvero fuori dal comune,
Lang Lang ha tenuto il suo primo recital ufficiale alla Scala, dove peraltro si
era già esibito recentemente accanto a due direttori prestigiosi come Barenboim
e Chailly. Lang non era nuovo al pubblico milanese, avendo già suonato in
Conservatorio nel novembre del 2003 senza suscitare particolare interesse. E
l’altra sera ha di nuovo messo in moto un meccanismo camaleontico attraverso il
quale egli sembra dapprima cercare e trovare un ampio consenso anche da parte
dell’uditorio più esperto (la sua lettura iperespressiva della Sonata in la
maggiore postuma di Schubert è stata innegabilmente di un certo fascino) per
poi dare il via a una sempre più libera interpretazione dei testi (la Sonata di
Bartok, eseguita con lo spartito, e una scelta di Préludes debussiani) fino ad
approdare a una girandola di effetti di cattivo gusto (disordinata e roboante
la Polacca op.53 di Chopin e semplicemente irriconoscibile lo studio
famosissimo op.10 n.3). Un pianista sicuramente ancora in fase di maturazione,
che va tenuto a freno ed è, come si dice, espressione dei nostri tempi, di un
“modo nuovo” di fare musica. Il fatto è che Lang, invece di elevare
illusoriamente al rango di grande musica anche degli innocui pezzi da salotto,
come facevano i grandi pianisti di un tempo, è capace di riportare la grande
musica al livello della canzoncina cinese che egli ha concesso come bis. Ecco
allora che Debussy e Chopin diventano il sottofondo di un piatto neanche troppo
raffinato di riso alla cantonese consumato in un ristorante di periferia.
Pubblico in delirio, standing ovations, ma uno dei maggiori sponsor di Lang,
Daniel Barenboim, si è limitato a una brevissima presenza nel palco della
sovraintendenza e ha pensato bene di andarsene alla chetichella : le ragioni
del marketing non riescono evidentemente del tutto a prendere il sopravvento
sulla sua enorme e raffinata musicalità.
Concerto del pianista Radu Lupu
Orchestra Enescu, direttore Christian Mandeal
Milano, Società del Quartetto, 28 Marzo 2009
The Classic Voice
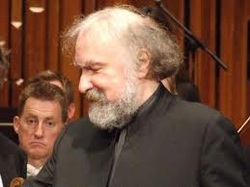
Radu Lupu si può oggi permettere qualsiasi cosa, anche di
leggere tra le righe di uno spartito ‘classico’ come il terzo concerto di
Beethoven e immaginare soluzioni che non sono esplicitamente annotate dal
compositore. Non è segnale questo di prevaricazione irrispettosa, ma di
fantasia estrema e di colloquio con un pubblico che lo ascolta in stupefatto
silenzio. Si, perché il pianoforte di Lupu va addirittura al di là
dell’imitazione del canto e riesce persino a trasformarsi in parola attraverso
mille inflessioni e a suggerire significati di estremo fascino anche
all’interno di passaggi apparentemente scontati, come il famoso incipit del
Concerto. Tre scale ascendenti nella tonalità di impianto esposte secondo
prospettive e sonorità differenti, una scoperta talmente semplice che non era
stata mai avanzata da interprete alcuno e che ha siglato fin dall’inizio una
lettura rapinosa ed estremamente inventiva di un testo che sembrerebbe oramai impossibile
descrivere con altri suoni, dopo duecento anni di pratica concertistica.
Lupu può prendersi queste ed altre libertà, anche pensando di trasportarci direttamente dalla perentoria affermazione beethoveniana alla misteriosa voce della foresta che viene evocata nel Vogel als Prophet dalle Waldszenen di Schumann, o alla malinconia ‘all’ongarese’ del terzo Momento Musicale di Schubert, bis preziosi che hanno se possibile reso ancor più incancellabile l’incanto della serata.
Lupu può prendersi queste ed altre libertà, anche pensando di trasportarci direttamente dalla perentoria affermazione beethoveniana alla misteriosa voce della foresta che viene evocata nel Vogel als Prophet dalle Waldszenen di Schumann, o alla malinconia ‘all’ongarese’ del terzo Momento Musicale di Schubert, bis preziosi che hanno se possibile reso ancor più incancellabile l’incanto della serata.
Recital del pianista Simon Trpceski
Milano, Serate Musicali, 20 Febbraio 2009
Recital del pianista Grigori Sokolov
Milano, Società dei Concerti, 4 Marzo 2009
The Classic Voice

Quasi in successione si sono potuti ascoltare a
Milano due importanti recital che danno una idea della sempre maggiore
richiesta da parte del pubblico di solisti in grado di proporre nuovi e
convincenti criteri interpretativi del repertorio classico.
Al suo debutto milanese, il trentenne macedone Simon Trpceski si presentava avendo alle spalle già un’ottima carriera internazionale e la sponsorizzazione di una importante casa discografica come la EMI, che lo tiene giustamente in considerazione come solista “di punta” del momento.
Attraverso un programma non certo confezionato per strappare l’applauso, Trpceski ha convinto il pubblico offrendo uno Chopin perentorio – splendida la Sonata op.35 – nel quale si sono ammirate delle doti tecniche di primissimo ordine (un suono sempre pieno ed estremamente pulito da un estremo all’altra della gamma dinamica dello strumento) e una capacità di sondare a fondo il difficile universo delle mazurke e delle polacche.
Grigori Sokolov è stato dal canto suo accolto trionfalmente come pianista di culto che è oramai circondato da una fama che sembra non avere confini. E’opportuno precisare, in questo momento della carriera del grande artista, quelli che sono i pregi e i limiti di un approccio che fa tesoro di una tecnica strabiliante nel porgere attraverso il pianoforte moderno la letteratura cembalistica che fa capo ai nomi di Byrd, Rameau, Couperin, Frohberger, Bach, con una resa di straordinaria perfezione del tessuto contrappuntistico e di una abilità da capogiro nel districare il groviglio di abbellimenti che affolla soprattuto il repertorio del barocco francese.
Questi strumenti non sono completamente sufficienti quando Sokolov si rivolge al mondo delle sonate beethoveniane, tantomento a quello di Schubert. Così la Sonata op.2 n.2 ci è sembrata più un algido trattato di belle maniere e di narcisistica perfezione formale che un coraggioso tentativo di far coesistere il nuovo secolo con quello di Mozart e Haydn e la Sonata op.53 di Schubert, della quale ritenevamo prezioso il ricordo di una recente esecuzione milanese da parte di Radu Lupu, perdeva completamente ogni risvolto poetico per limitarsi a una scansione perfetta del non facile tessuto meccanico, mantenuto oltretutto nei limiti di una velocità assai inferiore alla tradizione.
Al suo debutto milanese, il trentenne macedone Simon Trpceski si presentava avendo alle spalle già un’ottima carriera internazionale e la sponsorizzazione di una importante casa discografica come la EMI, che lo tiene giustamente in considerazione come solista “di punta” del momento.
Attraverso un programma non certo confezionato per strappare l’applauso, Trpceski ha convinto il pubblico offrendo uno Chopin perentorio – splendida la Sonata op.35 – nel quale si sono ammirate delle doti tecniche di primissimo ordine (un suono sempre pieno ed estremamente pulito da un estremo all’altra della gamma dinamica dello strumento) e una capacità di sondare a fondo il difficile universo delle mazurke e delle polacche.
Grigori Sokolov è stato dal canto suo accolto trionfalmente come pianista di culto che è oramai circondato da una fama che sembra non avere confini. E’opportuno precisare, in questo momento della carriera del grande artista, quelli che sono i pregi e i limiti di un approccio che fa tesoro di una tecnica strabiliante nel porgere attraverso il pianoforte moderno la letteratura cembalistica che fa capo ai nomi di Byrd, Rameau, Couperin, Frohberger, Bach, con una resa di straordinaria perfezione del tessuto contrappuntistico e di una abilità da capogiro nel districare il groviglio di abbellimenti che affolla soprattuto il repertorio del barocco francese.
Questi strumenti non sono completamente sufficienti quando Sokolov si rivolge al mondo delle sonate beethoveniane, tantomento a quello di Schubert. Così la Sonata op.2 n.2 ci è sembrata più un algido trattato di belle maniere e di narcisistica perfezione formale che un coraggioso tentativo di far coesistere il nuovo secolo con quello di Mozart e Haydn e la Sonata op.53 di Schubert, della quale ritenevamo prezioso il ricordo di una recente esecuzione milanese da parte di Radu Lupu, perdeva completamente ogni risvolto poetico per limitarsi a una scansione perfetta del non facile tessuto meccanico, mantenuto oltretutto nei limiti di una velocità assai inferiore alla tradizione.